Gianni Di Gregorio
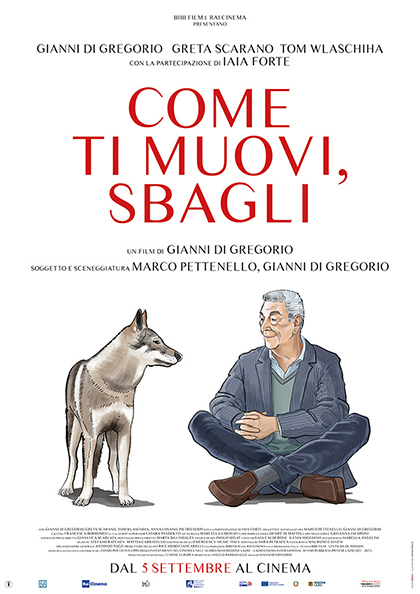
DATI TECNICI
Regia
Interpreti
Durata
Genere
Sceneggiatura
Fotografia
Montaggio
Distribuzione
Nazionalità
Anno
Presentazione e critica
La famiglia, il tempo che scorre, il matrimonio che si consuma, le seconde possibilità che riaffiorano quando sembravano ormai sepolte: è un film che non si limita a narrare gli eventi, ma apre uno spazio di riflessione sulla natura stessa dei legami, sulla fatica e sulla gioia di convivere, sull’inesorabile rischio dell’errore che accompagna ogni scelta di vita. Non è rifugio né luogo di armonia idilliaca: è un organismo vivo, in conflitto costante, capace di sostenere e insieme soffocare. La figlia che torna, il padre che si trova improvvisamente costretto a condividere spazi, il marito che affronta la propria crisi: ogni personaggio porta dentro di sé una tensione che si riflette sugli altri. Ci viene mostrata la famiglia come specchio in cui riconosciamo i nostri desideri e i nostri fallimenti, come teatro in cui siamo costretti a recitare ruoli sempre provvisori, mai del tutto scelti, spesso ereditati. Il professore è il simbolo di una vita congelata. Pensionato, avvolto nella sua routine rassicurante, ha trasformato l’immobilità in una forma di difesa. L’arrivo dei nipoti rompe quella gabbia di abitudini e lo costringe a rimettersi in moto: a cedere il suo spazio, a rinunciare al silenzio, a confrontarsi con la vitalità irruente dell’infanzia. I bambini diventano la vera forza rivoluzionaria del film: nel loro correre per casa, nel disordine dei giochi sparsi, nel vociare che riempie ogni angolo, incarnano la vita stessa che irrompe senza chiedere permesso. È attraverso di loro che il tempo ricomincia a scorrere, che l’anziano ritrova la possibilità di cambiare. È il suo viaggio dell’eroe, paradossale e quotidiano: da anziano abitudinario che osserva il mondo da lontano, diventa uomo che osa di nuovo vivere, che riscopre la possibilità di un amore, che trova il coraggio di dichiararsi quando sembrava troppo tardi. Non ci sono draghi da sconfiggere né battaglie epiche, ma la conquista è forse più ardua: uscire dalla propria apatia e rientrare nella corrente viva dell’esistenza.
Parallelamente, anche il marito di Sofia percorre il suo cammino. Il suo è un eroe diverso: un uomo che affronta la caduta di un matrimonio e il bisogno di ridefinirsi. Nel suo smarrimento e nelle sue esitazioni si riconosce la fragilità di chi, di fronte a un fallimento affettivo, cerca una nuova identità. In questo senso, il film disegna due traiettorie che si rispecchiano: il professore e il marito di Sofia, entrambi chiamati a riscrivere la propria vita, a reinventarsi in età e situazioni diverse, entrambi messi alla prova dalla necessità di scegliere. In entrambi emerge la vulnerabilità maschile: non più figure granitiche o autoritarie, ma uomini fragili, spaesati, capaci però di rinascere proprio nella loro fragilità. Il tempo è un altro protagonista silenzioso. Non scorre mai neutrale: pesa, grava, a volte sembra una condanna. Nella vecchiaia del professore si manifesta come immobilità, come paura di non avere più occasioni; nella vita di Sofia come urgenza di ricostruire, come ansia di non perdere altre possibilità. Ogni personaggio dialoga con il tempo in modo diverso, ma tutti ne sono condizionati: il tempo dell’amore, delle attese, dei legami che si logorano e di quelli che possono rinascere. Il regista ci ricorda che non esiste un momento “giusto”: l’amore può arrivare quando lo si crede impossibile, la vita può mutare direzione anche nell’età che sembrava destinata solo al ricordo. Il matrimonio, nel film, è visto senza idealizzazioni. Non come porto sicuro, ma come istituzione che può proteggere o intrappolare. Sofia, tornando, porta con sé il peso di un’unione fallita, e nella sua crisi si riflette un’intera generazione di donne che non accettano più di vivere ruoli imposti. Il marito, invece, incarna la possibilità di cambiare, di ammettere fragilità, di non nascondersi dietro un destino già scritto. Il film non giudica, non condanna, ma mostra: nel matrimonio come nella famiglia, l’errore è sempre possibile, eppure proprio da quell’errore può nascere un nuovo inizio.
Ciò che colpisce è il modo in cui Di Gregorio racconta le seconde occasioni. Non c’è retorica, non c’è euforia: c’è la delicatezza di chi sa che la vita non regala mai rinascite complete, ma piccoli varchi, spiragli che vanno riconosciuti e afferrati. Una dichiarazione tardiva, un gesto minimo, uno sguardo che si accende possono trasformare l’esistenza di un uomo. È qui che il film si fa universale: ci parla della possibilità di ricominciare sempre, a qualunque età, anche quando il corpo porta i segni del tempo e la mente si è convinta che tutto sia già deciso. Il titolo, “Come ti muovi, sbagli”, funziona come una sorta di filosofia esistenziale. Ogni azione, ogni scelta comporta un rischio, un inciampo, una quota inevitabile di errore. Ma il vero fallimento è non muoversi, restare fermi, lasciarsi pietrificare dall’abitudine o dalla paura. Il Professore scopre che anche sbagliare può significare vivere: meglio un sentimento imperfetto che la sterilità di una vita immobile. È un messaggio che non riguarda solo lui, ma tutti i personaggi, e forse ognuno di noi. Lo stile registico accompagna questa visione con la sua leggerezza inconfondibile. Di Gregorio non ha bisogno di scene clamorose: indugia su dettagli minimi, lascia parlare i silenzi, si affida al ritmo dei gesti quotidiani. È un cinema che non dichiara, ma suggerisce; che non impone, ma apre spazi di riflessione. Basta il fruscio di un pasto condiviso, il ticchettio dei piatti, il contrasto tra il silenzio del professore e il vociare dei nipoti per raccontare molto più di qualsiasi dialogo. La tenerezza con cui guarda ai suoi personaggi non è sentimentalismo, ma compassione autentica: un rispetto profondo per la fragilità umana.
Alla fine, non offre soluzioni, non promette catarsi definitiva. Ci consegna però una certezza: la vita non smette mai di sorprenderci, e ogni età porta con sé la possibilità di ricominciare. La famiglia, pur nella sua fatica, diventa il terreno in cui ci misuriamo con noi stessi; il tempo, pur nel suo peso, resta occasione di cambiamento; l’amore, pur nelle sue forme precarie e incerte, continua a essere la forza che ci tiene vivi. È un film che ci invita ad accettare la vulnerabilità, a non temere l’errore, a riconoscere nelle seconde possibilità la forma più autentica della libertà. E ci ricorda che l’eroismo quotidiano non sta nel compiere gesti straordinari, ma nell’avere il coraggio di amare ancora, di rischiare ancora, di dichiararsi quando sembra troppo tardi. Forse la vita non chiede perfezione, ma solo il coraggio di restare in movimento: anche se, come sempre, ci scopriamo a sbagliare
